Mario Ascheri
Formalismi di giuristi e di storici: un programma di lavoro?
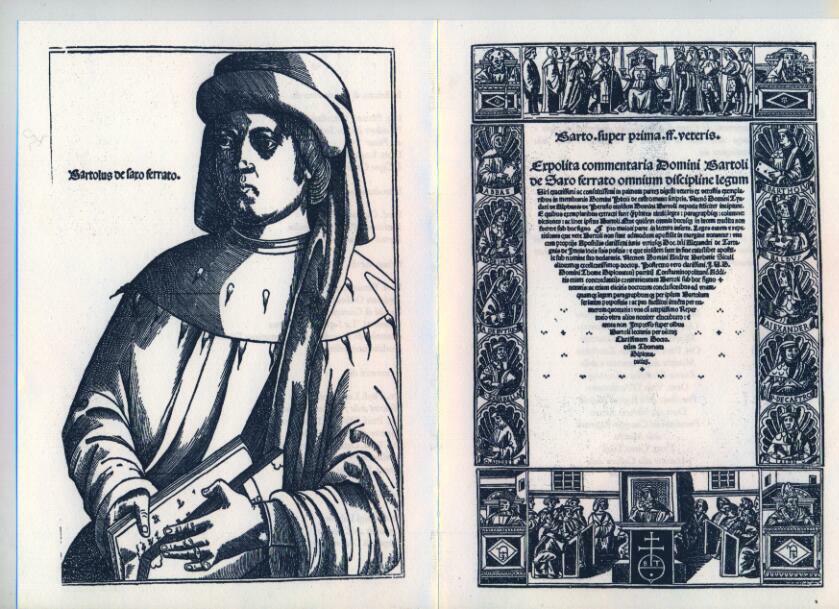
Mario Ascheri Formalismi di giuristi e di storici: un programma di lavoro? |
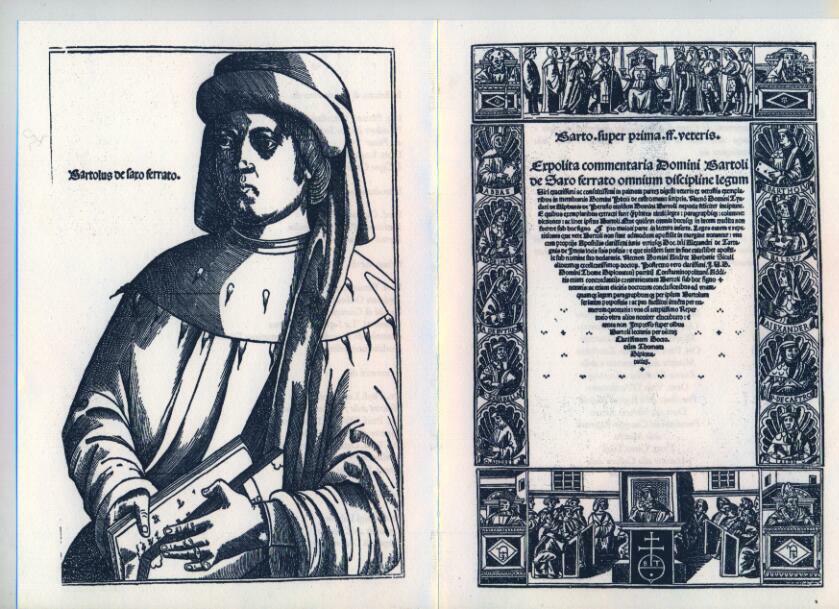 |
Credo
opportuno alternare a contributi specifici, analitici e
fortemente ancorati alle fonti, insomma a lavori che possono
aspirare a essere per certi aspetti definitivi, altri più ariosi
e propositivi, non dirò di metodo – che è divenuta forse
giustamente quasi una parolaccia -, ma su problemi di largo
interesse. Si corre naturalmente il serio rischio di scrivere
pagine del tutto provvisorie[1],
com’è in questo caso, o addirittura pagine in cui si dice
troppo o troppo poco e di cui ci si dovrà anche presto pentire.
Tuttavia, è utile intanto segnalare delle aporie, qualche
problema, degli assilli per rimediare ai quali si cerca il
dialogo e il conforto dei colleghi. Le pagine che seguono sono
tutto questo e al tempo stesso quasi un’espressione di
desiderio: nascono da esperienze di ricerca e ne postulano delle
altre; sono quasi un programma di lavoro, che non saprei dire
quando e come realizzare se non col concorso di altre energie e
competenze.
1. Per le
premesse, si può partire da una considerazione scontata per chi,
come me, si occupa di storia giuridica - pur alternandola con
altro tipo di approccio[2],
in particolare istituzionale. Ossia quella della
‘separatezza’ della Storia del diritto medievale e
moderno - questa è la dizione della disciplina storico-giuridica
capogruppo nel nostro attuale ordinamento - rispetto alle altre
discipline storiche in sede accademica, universitaria.
La disciplina
è stata per tanto tempo confinata solo nelle facoltà di
Giurisprudenza dove ha svolto e svolge funzioni molto diverse a
seconda delle singole sedi. Ora, sempre meno per la verità,
serve da introduzione culturale generale al diritto positivo
attuale, coprendo tradizionalmente l’incredibile arco
cronologico che va da Giustiniano fino ai nostri giorni; altre
volte (come avviene più spesso) vale come disinteressata
decorazione culturale, concentrata com’è in corsi o troppo
specialistici o troppo generici – spesso finora solo
medievistici, assunti dagli studenti senza poterne carpire le
virtù euristiche come una medicina cattiva ma necessaria, della
quale dimenticarsi comunque al più presto; oppure, ancora, essa
può essere al servizio di operazioni politico-culturali attuali,
consistenti nell’ammannire a piene mani a studenti inermi
(perché reduci da una scuola sostanzialmente de-storicizzata)
visioni ideologiche del passato ritenute evidentemente
‘formative’ per il presente. Date queste premesse, non
è difficile immaginare che la Storia del diritto italiano
(questa la denominazione usuale) abbia subito più di un
ridimensionamento nell’ambito della famigerata riforma
compendiata nella formula del ‘3+2’.
Il
confinamento, o la separatezza di cui si parlava, era facilitata
dal fatto che per tanto tempo la disciplina non ha avuto spazio
nelle facoltà di Lettere. Infatti, è stato a lungo un caso
isolato l’insegnamento (nella facoltà della Sapienza) di
Carlo Ghisalberti, il risorgimentista tanto poco in linea con gli
orientamenti dominanti della sua disciplina da essersi dovuto
trasferire in una cattedra di Storia contemporanea (cambiando
quindi totalmente settore disciplinare). L’inversione di
tendenza, con l’apertura di qualche corso, è relativamente
recente e dovuto ai corsi di laurea in Storia. Più recente
ancora è stato l’incontro con i corsi di laurea in Beni
culturali; un incontro importante o, meglio, un incontro che può
aprire prospettive importanti, ma che è rimasto mi sembra senza
una riflessione. Quale è la Storia del diritto più adatta per
gli operatori dei beni culturali? Chi si è chiesto se debba
avere una funzione specifica, e allora quale, in corsi di laurea
del genere? E se pure sarà individuabile, con quali strumenti
didattici andrà soddisfatta in quella sede?
Gli storici
del diritto non sembrano però molto impegnati su questo fronte.
La tendenza odierna più forte è a ricercare un rapporto da
tempo perduto con i giuristi positivi offrendo molto impegno
nella storia contemporanea, tradizionalmente trascurata e ora
invece divenuta campo quasi esclusivo della didattica un po’
per necessità e un po’ per opportunità. Inutile aggiungere
però che questi incontri ravvicinati sono assai pericolosi,
perché nascono da un’idea di ‘utilità’ della
storia di basso profilo[3],
e poi perché sono positivi solo se e quando riescono ad
affermare le specificità dell’approccio storico. In caso
contrario, con il fatto scontato che il giurista riconosce meglio
i fondamenti del diritto positivo – com’è anche ovvio
a ben vedere -, si può dare la sensazione dell’inutilità
stessa dell’approccio puramente storico. Ma non è questa la
questione che qui preme.
2. C’è
piuttosto una questione assai poco accademica e più di sostanza
da discutere e fare oggetto di ricerca. A parte l’utilità
pratica (segnalazioni di fonti, problemi tecnici con risvolti
pratici, ecc.) che la storiografia giuridica su ogni periodo
storico può avere per molte delle ricerche che conducono
parallelamente gli storici che di diritto non si occupano,
utilità che ha comportato sempre, come comporta oggi,
un’attenzione generica da parte di questi ultimi, c’è
da chiedersi a) se non ci sia anche un rapporto più stretto, una
contiguità per così dire osmotica tra la storiografia giuridica
e quella generale o di altra specializzazione, e se viene
accertato, b) chiedersi di che tipo essa sia.
Il problema si
pone perché all’apparenza gli intimi rapporti
esistenti nel corso dell’Ottocento (per non parlare
del passato ‘culto’ francese, ‘elegante’
nederlandese e ‘storico’ tedesco) sono progressivamente
andati sfilacciandosi. Le motivazioni sono molte e tutte da
considerare attentamente. Molto sommariamente qui richiamerò
taluni sviluppi culturali e politici. Ad esempio, osserverei che
la storia giuridica nella cultura storica italiana nel Dopoguerra
ha finito per soffrire (in misura ben diversa) di due tradizioni
distinte, ma convergenti sostanzialmente nell’isolarla.
Certe forme di idealismo (non Croce, ma alcuni suoi imitatori se
mai) la vedevano lontana dai grandi problemi e la ponevano su un
piano d’inferiorità culturale evidente. Era un po’ un
trascinarsi di vecchie polemiche, come quella che aveva visto
protagonista Pietro Bonfante, lo storico di Roma e del diritto
romano[4] che lavorò sulla scia del grande Theodor
Mommsen - che esemplarmente dimostrò con la sua opera concreta
quanto la felice fusione di ricerca filologica sulle fonti
giuridiche e le altre storie specifiche, la storia letteraria,
l’archeologia e l’epigrafia, potesse dare risultati di
grandissimo rilievo. Il ‘giuridico’ secondo questa
prospettiva rimaneva su un piano culturale secondario rispetto ai
problemi definitivi del ‘vero’ e del ‘bello’
della tradizione filosofica e letteraria (sembra di ripercorrere
l’itinerario del Petrarca…[5]);
peraltro, poi, se ne doveva contrastare la forte egemonia nel
mondo istituzionale e burocratico, crescente durante il periodo
fascista e tutt’altro che allentato nel nuovo mondo
repubblicano.
Una
convergente, più definitiva e più pesante condanna la decretava
poi la tradizione marxista rapidamente consolidatasi nel
Dopoguerra. Nella sua applicazione il diritto è stato vissuto
solo come una ‘sovrastruttura’, come un livello
condizionato da un certo assetto dei rapporti di produzione, e
destinato quindi a perire con l’apparato repressivo di cui
era un epifenomeno: lo Stato. Venuta meno la tirannia di classe e
del ‘suo’ Stato, nella vulgata marxista sarebbe venuto
meno anche il diritto, che aveva avuto storicamente la funzione
di coprire l’espropriazione di classe ai danni dei
produttori, conferendo coercitività alla repressione attuata per
via apparentemente contrattuale, ossia volontaria, nel rapporto
di lavoro.
Questa,
semplificata, la critica che ebbe tanto più successo quanto più
radicato apparve, nel nuovo clima politico del Dopoguerra, il
tradizionale metodo ‘tecnico-giuridico’ apparentemente
asettico e avalutativo, che aveva dominato durante l’epoca
fascista e che discendeva dalla autoproclamata
‘scientificizzazione’ della nostra dottrina giuridica
attuata grazie alla recezione e rielaborazione dei canoni della
Pandettistica tedesca a fine Ottocento[6].
La critica al
‘formalismo’ dei giuristi (bene simboleggiato dalla
giurisprudenza della Cassazione) per indicare la loro
insensibilità ai valori costituzionali e la loro subalternità
ai testi giuridici tradizionali – in primis al testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza – coinvolgeva anche
gli storici del diritto. Quel primo Novecento che aveva visto
ancora vivace l’indirizzo storiografico cosiddetto
‘economico-giuridico’ e i suoi fitti rapporti con la
storiografia giuridica era ormai un lontano ricordo.
Il boom della
produzione storiografica nel secondo Ottocento era stato marcato
infatti da un rapporto importante ed esplicito degli storici del
diritto con quelli ‘sociali’: pensiamo anche soltanto
ad un Salvemini, attentissimo come tanti altri ai fenomeni e alle
fonti giuridiche, viste come momento essenziale di comprensione
dei rapporti anche economici. Com’è ben noto, nel clima
ottimistico del positivismo scientistico si era creduto che
conoscere e pubblicare sempre più fonti desse più materiali per
accertare positivamente dei fatti che non avrebbero più avuto
nulla da nascondere, e perciò desse modo di scrivere una storia
oggettiva e definitiva come mai era stata possibile in passato
(salvo appunto per l’emergenza di nuovi fatti documentati).
Di qui l’incredibile corsa alla pubblicazione di cronache,
di statuti e di atti pubblici e privati, i quali tutti avrebbero
contribuito a fornire quel tot di conoscenza oggettiva,
documentaria, necessaria per approdare a dati oggettivi e perciò
definitivi.
3. La corsa
ebbe luogo in misura più ampia per il nostro Medioevo, che ha
avuto una presenza corposissima del diritto[7]e che quindi agevolò quel rapporto tra
storici di varie specializzazioni. Certo, le leggi e gli altri
atti pubblici, le deliberazioni di consigli e di collegi, così
come gli atti notarili, ci sono stati ieri come ci sono oggi. Il
problema è che le fonti giuridiche hanno nella documentazione
che ci è pervenuta per il Medioevo un posto assolutamente più
centrale rispetto ad altre epoche. Oggi - ma è così
ininterrottamente, a partire dall’Età moderna in poi - la
fonte giuridica è solo una tra le tante, importante sempre
(pensiamo anche solo al rilievo di norme pur particolari come
quelle sul voto segreto nella votazione di fiducia ai governi o a
istituti che possono produrre risultati eclatanti, come un
referendum), ma a volte anche fonte ideologica, di deformazione e
filtro della realtà, più che di informazione e quindi di
conoscenza storica.
Per il nostro
Medioevo invece il testo giuridico rivestiva un posto centrale
perché sono stati soprattutto gli atti aventi un rilievo
giuridico ad essere conservati, oltre ai grandi monumenti
dell’antichità trascritti dagli scriptores monastici
e universitari. Rispetto alle cronache, agli epistolari e alle
opere letterarie medievali, le opere giuridiche, i singoli atti
giuridici oppure le opere scritte, dei giuristi, sono
un’enormità, perché sono scritti per i quali esisteva un
preciso interesse alla conservazione. I documenti più antichi
della nostra stessa lingua sono dei verbali di placiti giudiziari
come in genere gli atti giuridici conservati interessanti enti
monastici o episcòpi, ossia gli enti che avevano la cultura e la
continuità istituzionale indispensabili per fondare la coscienza
dell’importanza della scrittura di un atto e della sua
conservazione. Non è un caso che siano atti giuridici quelli al
centro dell’introduzione alle fonti medievistiche scritta da
Cammarosano[8].
Basterebbe del resto già il fatto quantitativo a mettere in
guardia.
C’è
però anche il dato qualitativo. Se c’è un modo per
conoscere idee e fatti del mondo e della società medievale,
l’atto giuridico è quello più diretto per arrivarci.
Pensiamo alle difficoltà d’interpretazione di un documento
agiografico. L’atto giuridico può anch’esso richiedere
una lettura attenta, perché frutto della cultura del suo autore
più che del soggetto titolare del rapporto giuridico che
l’atto documenta; vero cioè che ci dice più del notaio che
ha registrato l’atto o la deposizione o del cancelliere che
ha preparato il testo della legge che non del contraente, del
teste o del re che hanno voluto l’atto di rilievo giuridico.
E tuttavia ci dà immediate informazioni sulla società che
l’atto produce, nonostante la fissità relativa dei
formulari notarili e la permanenza attraverso i secoli di certe
funzioni e necessità degli atti giuridici: pensiamo
all’immediata (anche troppo e perciò talora fuorviante)
leggibilità dei provvedimenti comunali! L’atto giuridico
esprime direttamente una necessità sociale, una funzione, una
tessera della realtà, anche se c’è sempre una mediazione
culturale, che reca una testimonianza di chi all’atto ha
dato una veste formale. Ma c’è qualcosa di più.
Il Medioevo
italiano, in particolare e più d’ogni altro, proprio
perché viveva dell’eredità romana, è stato dominato,
direi quasi ossessionato, dal diritto. I grandi conflitti
assumevano immediatamente una veste giuridica, come giuridica era
la veste delle grandi novità che hanno segnato delle svolte
fondamentali nella storia europea: e grazie al culto in gran
parte italiano del diritto. Chiesa e Impero, Comuni e feudi,
popolo e nobiltà, università, ordini religiosi, corporazioni,
confraternite ecc.: tutto acquisiva veste giuridica; tutto aveva
– come infatti ancora diciamo espressivamente - il proprio
‘statuto’...
4. Perciò la
grande ricerca svolta sulle fonti medievistiche favorì
potentemente quel rapporto tra storici di diversa formazione. Col
tempo e con la crisi della ragione che tanto ha segnato il
Novecento, però nessuno credette più alle premesse
positivistiche, quanto meno se prese in senso apodittico. Il che
ha contribuito – col confermato ‘formalismo’ dei
giuristi - ad accrescere nel Dopoguerra la diffidenza nei
confronti delle fonti giuridiche e quindi anche della
storiografia giuridica. Le fonti giuridiche erano mistificanti:
come la nuova Costituzione, facevano intravedere proclami e
valori tutt’altro che rispettati nella ‘prassi
sociale’; a questa bisognava finalmente guardare, altroché
a normative puramente ideali e fuorvianti!
Perciò,
nonostante gli accenni a una recente inversione di tendenza, la
storia giuridica continua oggi ad esser vissuta da molti tra gli
storici non del diritto (e più in Italia che altrove) come una
storia da un lato troppo tecnica, una storia di
‘formalismi’[9],
e dall’altro come storia di
‘Azzeccagarbugli’, di ceti professionali soltanto e per
di più parassitari, legati in modo opportunistico a una
struttura sociale e a una divisione di ceto o di classe
profondamente ingiusta. Queste convinzioni vengono peraltro
facilmente confermate dai molti prodotti storico-giuridici oggi
in circolazione che si risolvono in trattazioni minuziose di
casistiche puramente dottrinali, senza riscontri documentari e
contestualizzazioni storiche, quasi esercitazioni scolastiche che
hanno dato vita a una specie di post- o para-Pandettistica
che cerca anacronisticamente di creare ex post un
‘sistema’ dove (nel diritto comune) esso
non c’era o non c’era certamente di tipo pandettistico.
Si arriva al punto, di fronte a queste ricostruzioni dottrinali
che si avvitano su se stesse, che i filosofi del diritto possono
essere paradossalmente più storici degli storici, come ha
mostrato in modo esemplare Giovanni Tarello, il filosofo genovese
prematuramente scomparso[10].
Perciò gli
altri storici si rifanno ai rapporti di potere che contano, e
quindi alla politica e all’economia, che possono meritare
grande rispetto e considerazione, oppure – secondo i nuovi
impulsi – all’antropologia, alla storia delle
mentalità o più in generale alla storia culturale di lungo
periodo, ‘costituzionale’.
In queste
prospettive i giuristi appaiono del tutto subalterni al
‘sistema’ e i loro storici allineati con esso a
fornirne motivi più o meno forti di legittimazione sociale e
culturale. Vale a poco osservare, del tutto banalmente, che la
cultura giuridica è la cultura degli apparati dello Stato, a
cominciare da quelli fondamentali del potere legislativo e
giudiziario, e che essa ha poi un’enorme diffusione tra
categorie larghissime d’operatori sociali diversissimi, dai
consulenti del lavoro e fiscali ai sindacalisti, ai politici ecc.
ecc. La cultura di questi e i loro prodotti, un’infinità di
libri, riviste e raccolte giurisprudenziali, rimangono confinati
in un ambito ritenuto tecnico-professionale, non degno
d’attenzione da parte del raffinato uomo di cultura per
così dire ‘generale’. Il problema di capire quella
cultura non si pone neppure, perché la si confina piuttosto in
un’area di ‘non cultura’, con la quale quindi non
è necessario fare i conti per definizione[11].
5. Il
risultato è un reciproco disconoscimento che comporta
conseguenze a mio avviso deleterie, e che vanno ben al di là di
quel che singoli esempi possano lasciar supporre. E non già
perché il mondo del diritto sia un mondo di bontà disconosciuta
– ci sono mille buoni motivi per lagnarsene, e non solo per
il diritto di oggi -, ma perché il diritto in sé è piuttosto
uno strumento, di cui quindi si può fare, come di ogni
strumento, un uso buono o cattivo; il che vale per il mondo
d’oggi, ma lo stesso si può dire per ieri. È banale
ricordare che sono pur sempre diritto la normativa che garantiva
la schiavitù personale o le procedure inquisitorie, allo stesso
modo che era ed è diritto il complesso di interventi che hanno
eliminato e l’una e l’altra: convenzioni internazionali
devono tentare ancor oggi (con scarso successo per la verità) di
impedire che il commercio di persone abbia luogo, mentre altri
accordi e la sensibilità politica cercano di eliminare dalla
nostra teoria e prassi (anche qui senza grandi conquiste) le
procedure inquisitorie.
Ma oltre a
ciò, andrà ancora ribadito che il diritto ha una importanza
fondamentale per aprirci alla comprensione del passato? Il
fenomeno giuridico vi è così corposamente presente che è una
dimensione di cui dobbiamo essere in qualche modo ben
consapevoli, bon gré ou mal gré. E siamo al
lapalissiano. Direi perciò anche di più.
Il mondo
giuridico è elemento costitutivo di una cultura diffusa che va
ben al di là degli operatori del diritto. L’assunto che
credo sia urgente verificare, cioè, è che esso non sia affatto
quel mondo conchiuso, che si può pensare risolversi in formule
notarili o legislative; quelle che possiamo tranquillamente
dimenticare non appena fatto l’atto o osservata la norma. La
separatezza del mondo giuridico e storico-giuridico di cui si è
parlato non significa né implica anche un’estraneità degli
storici ‘generali’ o di altre specializzazioni da quel
mondo e dalle sue categorie.
Spiego meglio
la mia impressione-ipotesi di lavoro. Per quanto si tenti talora
disperatamente, come le tre scimmie, di non avere a che fare col
diritto, e per quanto ci sia un’apparente estraneità
degli storici ‘altri’ dal diritto, esso finisce per
invadere e pervadere ogni giorno loro come tutti noi, e non solo
nella quotidianità del contemporaneo. Quel che più è grave è
che esso ci condiziona nel nostro tentativo - quale che sia
l’angolo visuale prescelto - di comprendere il mondo del
passato – qualunque passato del nostro mondo. Questo perché
le categorie con cui noi andiamo alla scoperta del passato
europeo sono spesso intrise di giuridicità: sono quelle che
hanno cooperato a fare il mondo moderno e che noi filtriamo
consapevolmente o meno dal mondo giuridico odierno.
E qui bisogna
aprire una parentesi, perché diviene rilevante il problema della
‘storia generale’, categoria che va anch’esso
ridiscussa, a mio avviso. La mia impressione è che ogni storia
‘generale’, del Medioevo come dell’Età
contemporanea ecc., regga solo come istituzione universitaria,
come espediente didattico o narrativo (per poter disporre di una
Storia della Francia, del Papato ecc.). Darei infatti come
acquisizione pacifica che la storia generale come disciplina con
un proprio statuto, in sé, sia una pia illusione, un po’
come lo furono gli assunti positivistici. Vero che bisogna
tentare di fare storia ‘globale’ come ci hanno
insegnato le “Annales”, si suole dire, ma questo vale
per tutti gli storici, non solo quelli ‘generali’, dato
che non possiamo tralasciare interi livelli di realtà privi di
attenzione solo perché non ci piacciono o perché non sono mai
stati considerati prima. Geografia e clima, alimentazione e
abbigliamento, il genere, il sesso e la famiglia, le tecniche e
così via si sono aggiunti ai più tradizionali interessi
storiografici e hanno posto un’infinità di domande nuove,
che hanno consentito di guardare in modo nuovo e più
problematico ai problemi più tradizionali.
C’è una
circolarità dei problemi in ogni contesto, una loro variegata
complessità che fa rinviare da uno a un altro, per cui non ci
sono livelli separabili se non arbitrariamente e/o per le
(inevitabilmente) ristrette competenze dell’osservatore. Le
storie specialistiche non sono compiute in sé, sono storie
dimezzate se escludono le altre; ma non c’è neppure,
compiuta in sé, una presunta ‘storia generale’ di
livello superiore, che possa prescindere dalle storie
specialistiche: per il semplice fatto che la cosiddetta storia
generale... non esiste.
Quelle che noi
chiamiamo nelle università ‘storie generali’ delle
varie epoche sono per lo più delle storie sociali arricchite con
qualche spunto più o meno ben miscelato di storia politica e
religiosa, di storia delle mentalità e di storia economica,
quando non si risolvano di fatto semplicemente in corsi
specialistici essi stessi; quelli che, dato per manuale formativo
di base il libro della scuola secondaria (rimasto a suo tempo
più o meno intonso), si incentrano sulla storia del territorio
(ora anche considerato ‘micro’) o della cultura
universitaria o popolare, della chiesa o della religiosità e
così via secodo gli interessi del docente. È tanto difficile
(perché impossibile) una storia generale che fioriscono le
storie speciali. Esse di quella sono non tanto negazione, quanto
dimostrazione della sua inesistenza. Una
storia‘generale’ nei programmi didattici è da un lato
solo un espediente, una convenzione (corrisponde a quel livello
di conoscenze minime che si ritiene di dover assicurare alla
cultura generale dello studente medio), e dall’altro un
modo, una volta prolificati a dismisura i corsi, per creare e
istituzionalizzare delle gerarchie tra i colleghi di una
facoltà.
Va da sé che
quel livello minimo cambia in base alla cultura e alle opzioni
del docente o del ceto accademico di cui fa parte, un livello non
oggettivo e per tanti aspetti arbitrario. È più chiaro se
pensiamo a problemi più discussi: cos’è necessario far
sapere di Storia contemporanea oggi? Che equilibrio, ad esempio,
ci deve essere tra storia del Fascismo e della Resistenza e del
movimento comunista, tra crimini nazi-fascisti e crimini
comunisti? È recente la disputa sulla ‘faziosità’
della storia contemporanea, che mutatis mutandis si
potrebbe naturalmente trasferire alla storia del passato meno
prossimo, anche se sono meno evidenti le inevitabili opzioni del
docente. Crociate ed inquisizione, o Vandea e altre atrocità
rivoluzionarie, fanno parte della storia generale? E se la
risposta è sì, cosa se ne deve dire oggi?
6. Ma al di
là del problema didattico e formativo, che non è qui in
discussione e che pure è fortissimo, il punto sul quale va
portata l’attenzione è che la scarsa o nulla considerazione
al mondo giuridico, che si è riprodotta nei termini e modi
rapidamente enunciati, è un fatto culturale con una sua vicenda
profondamente radicata nella nostra storia se fu già ben viva in
quel Rinascimento italiano che vide la ‘disputa delle
arti’; perciò dobbiamo considerarla con attenzione.
Intanto,
perché è vero che apparente o reale che sia quella
‘separatezza’ non impedisce affatto l’osmosi di
problemi, di concetti, di pregiudizi dall’un mondo
nell’altro: da quello giuridico in quello
‘generale’, del comune sentire, epperciò anche nel
mondo storiografico che ne è specchio e per certi aspetti
‘organo di governo’ attraverso la scuola e i media.
E siamo
finalmente al cuore dell’ipotesi di ricerca che più mi
preme.
C’è, e
allora quale è, un influsso della cultura giuridica su quella
‘generale’ e quindi anche sugli storici più o meno
operativi come ‘generali’ o su altrespecializzazioni?
L’ipotesi sulla quale credo utile lavorare è che si debba
rispondere positivamente: che quell’influsso esista e che
esso sia tanto più importante in quanto rimane per lo più
inconsapevole; rimane un elemento di fatto, filtrato col latte,
per così dire, inconsapevole, irriflesso; perciò e quindi anche
tanto più pericoloso.
Il mondo
giuridico, lo sanno e lo dicono tutti, è il mondo del
formalismo, il mondo che cura le ‘forme’ degli atti al
di là della loro sostanza; si appaga di certe formalità senza
le quali un atto è invalido o nullo oppure da assegnare a
un’altra categoria di atti. È mondo di precisione
concettuale, che non ammette confusioni o che cerca di risolverle
se ci sono. Qualifica un atto per certe caratteristiche e da esse
fa discendere conseguenze precise di tipo giuridico, positive o
negative per un certo soggetto, retto com’è da una logica
semplice, della non contraddizione. Proprio perché vuole e deve
assicurare stabilità e chiarezza ai rapporti tra i
‘consociati’, come si suole dire, i rapporti umani che
in natura sono tutt’altro che stabili, chiari e certi
ricevono dal diritto quel quid di ‘innaturale’
che è la stabilità e univocità mediante il crisma della forma.
Per dar ordine ai rapporti umani, la mentalità giuridica deve
tipizzarli, e perciò anche qualificarli in modo astratto e
altrettanto astrattamente distinguerli. Insomma, è come
esemplarmente procede il giudice, che è alla ricerca degli
‘estremi’ che permettano di riconoscere una
‘fattispecie’; una volta che essa sia stata
riconosciuta le conseguenze sono automatiche. Non entriamo qui,
naturalmente, nei problemi dei processi interpretativi e
dell’ideologia che li sorregge. Basta renderci conto che
questo fare apparentemente meccanico, questo ‘formalismo',
ha un suo significato profondo. Come nelle procedure legislative,
esso significa o dovrebbe significare rispetto delle regole,
trionfo del principio di legalità, garantismo. Ma questo
procedere per opposizioni nette tipico del mondo giuridico
finisce per influire in modo deleterio se recepito tel quel
nel ragionamento dello storico. Facciamo un esempio.
7. Pensiamo
alla tipica contrapposizione che vien predicata tra quel mondo
feudale e mondo capitalistico odierno – congiunti se mai da
una lunga ‘transizione’, si dice (o piuttosto si
diceva). Il mondo feudale era caratterizzato dal rapporto diretto
del produttore con i mezzi di produzione e dalla coercizione di
quel lavoro, perché il colono era obbligato con la forza
del signore o dei suoi scagnozzi ad usare di quei mezzi di
produzione; anzi, era lui stesso considerato un mezzo di
produzione come la terra e il bestiame. Nel mondo capitalistico,
superata la transizione con le sue infinite figure intermedie,
non c’è più coercizione diretta, perché il produttore è
stato espropriato dei mezzi di produzione e semplicemente può
dare forza-lavoro con un rapporto contrattuale libero.
In una
ricostruzione del genere, che pure fa parte della vulgata
marxista, c’è moltissimo di giuridico (com’era tipico
del mondo tedesco del secolo scorso[12]). Tutto lo schema nei suoi termini
essenziali è impostato in modo giuridico, perché prima
si parla di una coercizione caratteristica che diviene poi - a
contrario - libertà contrattuale. Ma non è un
bell’esempio di formalismo giuridico trasbordante in campo
altrui?
A ben vedere,
quella coercizione era un rapporto di potere, tanto spesso
peraltro rovesciato a favore del prestatore d’opera grazie
alla forza contrattuale di cui disponevano i villaggi a fronte di
un signore assenteista e con tutt’altri problemi;
ugualmente, nel mondo contemporaneo quella ‘libertà’
contrattuale è essa stessa un bel formalismo, perché il
contratto di lavoro è tra i meno liberi in assoluto (un tempo
squilibrato a favore del datore di lavoro e ora, invece, ancora
per qualche tempo almeno, a favore o con maggior tutela del
lavoratore), un po’ come quello di chi chiede un servizio
pubblico o contratta con una grande impresa, che può solo
aderire ad uno schema contrattuale che non lascia alcuna
libertà.
Nell’un
caso e nell’altro sono le condizioni concrete, le situazioni
del contesto che spiegano e dicono chi avesse il controllo del
rapporto di produzione, non gli schemi giuridici. Libertà
contrattuale e necessità coesistono anche nella stessa
‘formazione economico-sociale’ – se vogliamo
continuare ad usare categorie marxiane. La libertà contrattuale
dei moderni, quella che sarebbe stata assicurata dai moderni
codici - tra breve se ne parlerà tanto per le celebrazioni del
bicentenario del Codice civile napoleonico - fu affermata assieme
alla sua negazione più netta. Ad esempio prima si potevano
fondare con i fedecommessi — ossia con manifestazioni di
volontà che duravano attraverso i secoli[13] - dei patrimoni destinati a certi scopi;
buoni o cattivi che fossero per noi oggi, allora lo si poteva
fare; dopo, non più, in ossequio a un’altra libertà che si
volle preminente: quella della circolazione dei beni sul mercato.
Altro esempio,
ben presente a chi lavora sul Medioevo. Gli storici oppongono un
Medioevo in cui non vale l’individuo in quanto tale, ma solo
come membro di un’entità associativa, il ceto o la
corporazione, al mondo moderno come luogo dell’individuo per
definizione[14]. A ben vedere si tratta di nuovo di una
contrapposizione formalistica, di una semplificazione frutto di
mentalità giuridica astratta. Vero che c’erano dei gruppi
esclusi dal potere politico, oppure da quello dei privilegiati
delle città (pensiamo anche soltanto a tutti gli abitanti del
‘contado’ che avevano un trattamento diverso dai
‘cittadini’), ma ciò non vuol anche dire che non ci
fosse la tutela individuale dei diritti. Certo, se si aveva
dietro, a dar forza alla propria richiesta, un gruppo era molto
meglio. Ma oggi non succede forse lo stesso? Proclamata la tutela
individuale dei diritti (presente anche negli statuti
medievali, beninteso) si conferma sempre più che se non si fa
parte di una qualche corporazione, da quella dei docenti a quella
dei consumatori a quella di un partito o di un sindacato, certi
diritti sono praticamente intutelabili. Di nuovo la
contrapposizione tra antico e moderno è una contrapposizione che
la storia cosiddetta generale basa su un assunto formalistico; o
meglio, su un assunto giuridico, e peraltro schematico e di
difficile verificazione.
Tutela dei
diritti. Si pensi a quello che si è detto dell’Inquisizione
e a quello che si va dicendo in sede di revisione (più che
revisionismo) dei giudizi storici tralatizi. Oggi John Tedeschi e
tutto sommato lo stesso Adriano Prosperi ne danno
un’immagine ben diversa: Inquisizione come istituzione ben
ramificata sì, onnipresente e attentissima fino
all’ossessione, ma anche formalmente (e apparentemente)
rispettosa dell’inquisito grazie all’infinità di carte
necessarie per decidere alcunché (c’è già tutta la nostra
cultura processual-penalistica...); segreta nelle procedure[15] proprio per non danneggiare
1’inquisito (e qui abbiamo addirittura fatto passi
indietro!), rapida (no comment sull’attualità) e
così via. Ad essa viene contrapposto un sistema giudiziario
‘moderno’ che ha realizzato molto di più? La
carcerazione preventiva non è peggio di una pena medievale?
Nell’opporre
antico e moderno gli storici si servono per lo più di un
formalismo che è tipicamente giuridico: va meglio oggi,
perché… la legge dice che va meglio, ispirandosi di regola
a nobili idealità egualitarie e solidaristiche.
A stare a quel
che viene scritto e proclamato nei nostri testi normativi attuali
e ad opporlo testualmente, com’avviene in molta storiografia
giuridica e non, a testi del passato siamo senz’altro nel
mondo delle meraviglie e le discontinuità non si contano. Ma
quel culto retorico della ‘forma’, la tendenza ad
affermare più che a realizzare, a proclamare diritti più che
rispettarli nei fatti, in una parola la tendenza a limitarsi a
creare delle belle ‘forme’, era già tutta nel nostro
Dna.
Ecco dove
l’ipotesi di una prevalenza inespressa della cultura
giuridica mi sembra molto plausibile: in questa fiducia per
l’affermazione scritta, più meritevole di attenzione del
reale; in questa tensione a deliberare riforme più che a
realizzarle concretamente; in questo perenne dire più che fare o
proporre senza verificare.
Astrattismo,
velleitarismo, formalismo sono caratteri profondi della nostra
cultura che abbiamo in comune con e dalla cultura
giuridica. L’ipotesi è quindi che sia ‘separata’
solo apparentemente. In realtà essa è dentro di noi, forma un
tutt’uno con la nostra cultura: perciò bisogna riconoscerla
per poterla controllare, dominare, e superare; altrimenti,
c’è il rischio di rimaner schiavi inconsapevoli della sua
cultura.
Prendiamo
un’altra opposizione tipica. Il Medioevo, si dice, è privo
di costituzione, e ad esso si contrappone la modernità
costituzionale; il periodo dei privilegi è contro il periodo dei
diritti[16]. Non è uno schema formalistico in cui, di
nuovo, siamo vittime di uno schematismo tipicamente giuridico? La
costituzione nel Medioevo c’era eccome, sia negli
ordinamenti monarchici che in quelli comunali. Sarà stata più
consuetudinaria nei primi e più legislativa nei secondi, e
perciò più di tipo moderno dal nostro attuale punto di vista
nei secondi; ma ciò vale solo per un continentale, perché un
suddito di Sua Maestà britannica naturalmente valuterebbe la
modernità in modo opposto. Comunque, non solo c’era la
costituzione, ma i poteri dei re si ritenevano addirittura più
limitati dei poteri dei governi comunali, che - rilevava
Machiavelli – “insalvatichivano” i vicini
(esempio di Firenze in Discorsi, II 21). I re, di solito,
erano tutt’altro che assolutisti, vincolati com’erano
dalle istituzioni rappresentative dei ceti.
Lo stesso
‘assolutismo’ moderno di cui si parla risponde a un
formalismo giuridico, perché a ben vedere i sovrani cosiddetti
‘assoluti’ furono assai pochi e solo in circostanze
eccezionali poterono operare. Fu piuttosto la regola il governo
‘partecipato’ dai ceti o dualistico, diviso con le
amministrazioni locali, che ebbero competenze sempre larghissime
fino al trionfo dei centralismi ‘nazionali’ e delle
burocrazie ottocentesche. C’è chi parla di un vero
assolutismo, o per meglio dire di ‘assolutismo
legislativo’, solo per l’Ottocento, quando i governi ad
esempio ardirono confiscare i beni delle chiese, cosa mai
successa in passato, salvo alcuni interventi riformatori
settecenteschi. Ma si può opporre: forse che i condizionamenti
di ceto (o di classe, meglio) allora non operavano? Non è forse
quello il secolo della borghesia e dello Stato
‘monoclasse’?
Certo, il
costituzionalismo moderno-contemporaneo va di pari passo con un
‘autoritarismo’ che sembra del tutto nuovo, anche
perché ha chiesto come non mai il sacrificio in massa dei
sudditi. Ma non mi sembra che le stesse prassi di governo fossero
ignote ad esempio ai nostri Comuni-città-Stato medievali.
Ma allora
quelle contrapposizioni tra grandi epoche, squarciati i
formalismi di tipo giuridico, si dissolvono?
Certo, svolte
ce ne sono, ma a volte sono altre, diverse da quelle dichiarate,
oppure assai meno pronunciate di quanto il formalismo non ci
abbia abituato a pensare. Il fatto che oggi tutti apparentemente
abbiano i diritti politici quando sono cittadini di un
ordinamento sembra incompatibile con un ordinamento feudale e fa
pensare ottimisticamente di essere in una situazione speculare
rispetto a quella feudale del Medioevo. Ma è un’ingenuità
palese, anche se rassicurante. Solo un ennesimo formalismo
storiografico ci può far pensare a incompatibilità assoluta dei
due tipi di ordinamenti.
I sistemi
presidenziali attuali (ma il discorso può proporsi mutatis
mutandis per quelli ‘partitocratici’[17]) a partire da quello stesso
americano, ad esempio, che si vuole importare (peraltro senza i
suoi ‘pesi e contrappesi’, fortissimi in America e tali
da garantire una relativa, come sempre, democraticità del
sistema) hanno precisi profili feudali proprio sotto il
piano sostanziale, squarciato il velo del formalismo
giuridico-politico. Lo spoil system, che consente al
vincente di piazzare tutti i propri uomini nelle posizioni che
contano (prontamente imitato naturalmente da noi, ma senza nulla
della cornice garantistica presente negli Usa) è anzi, a ben
vedere, una forma di feudalesimo puro.
Sono dei
‘fedeli’ in senso proprio quelli piazzati nelle varie
lucrosissime poltrone (non è ‘rendita’ e della
peggiore quella a spese e in nome dell’interesse pubblico?),
persone che hanno di fatto promesso la loro fedeltà in cambio di
protezione come nel più puro schema feudale; come nel più puro
schema feudale; come nel modello feudale ideale, infatti, essi
sono licenziabili ad nutum, cioè a puro arbitrio del
Signore concedente il beneficium. Fu l’edictum de
beneficiis italiano[18] a dare un’adeguata protezione ai nostri
vassi lombardi e a rompere, pertanto, la licenziabilità
da parte del concedente; dopo Corrado II, da un punto di vista
strutturale il feudo ‘lombardo’ divenne come un posto
nell’amministrazione pubblica italiana in base alla nostra
legislazione (peraltro in via di destabilizzazione profonda): un
posto dotato di protezione e fissità (e spesso anche
ereditarietà) secondo lo schema sindacal-corporativo.
L’ufficio stabile, acquisito una tantum, intoccabile
a vita, aveva nel passato come oggi un rilievo importante,
perché dava una libertà inimmaginabile, un’indipendenza
che oggi è sempre più in pericolo negli uffici pubblici (vista
1’estrema politicizzazione dominante) una volta introdotta
l’instabilità del posto di lavoro.
Si pensi a un
altro esempio istruttivo. Quando ci si scandalizza della
venalità degli uffici in età moderna - peraltro anticipata da
quello ‘Stato moderno’ ante litteram che fu
l’apparato pontificio - si dimentica (formalisticamente
appunto) che troppo spesso ancor oggi gli uffici vengono
comprati, pur se in modo formalmente pulito, ad esempio camuffato
da corsi di formazione - e prescindendo ovviamente dalla
corruzione, sempre possibile, e certamente non meno diffusa che
nel passato. Siamo al punto che dietro adeguato compenso certe
agenzie specializzate sono praticamente in grado di garantire
l’elezione a deputato. Venalità e simonia,
quindi, sono scomparse solo come categorie, non come realtà di
fatto. Ma nei testi normativi attuali non se ne parla, per cui si
possono creare delle belle opposizioni nette, che fanno scorrere
fiumi di moralismo storiografico – inutile dire quanto
controproducente sul piano didattico e formativo. Con le
loro discontinuità a volte fittizie, vittime di slogan del
concettualismo giuridico, gli storici finiscono per condannare il
passato e legittimare il presente. Il moralismo è per lo più a
senso unico: funziona meglio quando rivolto contro il passato.
Basterà
richiamare all’uso che vien fatto della categoria di
‘oligarchia’. Se ne parla per il passato da condannare
con una frequenza esasperante. Come dubitare che il periodo
consolare dei Comuni fosse oligarchico, se fu seguito dalle
rivolte del ‘popolo’? A ben vedere però anche questo
‘popolo’ era fatto di grassi borghesi, e pertanto
anch’esso era non meno oligarchico; poi, quando prevalsero i
paradigmi nobiliari come si poteva non essere in un mondo
oligarchico? E il notabilitato ottocentesco col voto addirittura
censitario?
Insomma, solo
il suffragio universale può convincerci e rassicurarci di essere
pervenuti alla soluzione, al superamento dell’oligarchia.
Non è anche questo formalismo? Nel Dopoguerra democratico, ricco
di infiniti aspetti positivi, beninteso, i fili della vita
pubblica sono stati retti da un gruppetto di politici
autoperpetuantisi attraverso gli schermi dei partiti, con un
‘centralismo democratico’ che è stato il vero trionfo
dell’oligarchia come mai in passato (salvo il fascismo,
naturalmente, che però è durato assai meno...). I più
intelligenti e prudenti, come in ogni seria oligarchia, sono
passati indenni attraverso le vicende più incredibili e
contraddittorie: fare dei nomi credo sia superfluo –
oltreché imbarazzante. Cambiamo scenario e i problemi e certe
soluzioni non cambiano.
La Francia
moderna con i suoi giudici ‘venali’ dei parlamenti
aveva dei funzionari che potevano sfidare il loro re, esattamente
come potevano fare i nostri vassi lombardi alleandosi tra
loro e costituendo i Comuni, oppure come facevano i dipendenti
pubblici fino a pochi anni fa: un segretario comunale, che un
tempo poteva-doveva opporsi al suo sindaco, è dubbio che lo
possa fare oggi, dipendendo in tutto da lui...
Formalismi
ovunque, frutto d’un trionfo attuale (e che si tarda a
riconoscere) della mentalità giuridica, che vuol dire impulso a
ragionar per schemi, più che per funzioni, per proclami più che
in base ai dati di fatto, alle analisi serie, che pure ci sono.
Perché il sistema ammette la contraddizione, ma sa come
metabolizzarla. Pensiamo ai nobili discorsi dei Procuratori della
Repubblica a inizio di anno giudiziario, o a quelli della Corte
dei conti sulle malefatte della spesa pubblica sotto qualsiasi
governo: ci può essere qualcosa di più realistico e al tempo
stesso di più inutile? Non risulta che abbiano mai dato avvio a
qualcosa di veramente serio, visto che sono mancati interventi
efficaci che precludessero le stesse lagnanze ogni anno. Pensiamo
ancora, sempre per essere concreti, alla proclamazione
dell’obbligatorietà dell’azione penale. Nessuno ci
aveva mai pensato in passato e invece nella nostra parenetica
Costituzione c’è, naturalmente: perché è un valore,
importantissimo, ma purtroppo rimane solo tale; perché è un
valore contraddetto nella pratica di tutti i giorni, in cui si
vedono privilegiati certi filoni di repressione anziché altri,
ovviamente (e spesso giustamente, beninteso), e perché,
soprattutto, è un valore impossibile: nessun apparato di polizia
potrà mai essere sufficiente a verificare con un pari impegno
ogni possibile reato commesso.
Il formalismo
quindi (non il rispetto delle forme, del diritto, che è altra
cosa) è parte importante della nostra cultura; anzi, lo è oggi
più che mai. Ma quanto e come e con quali conseguenze ci
condizioni è questione da approfondire, almeno per me. Perciò
concluderemo solo provvisoriamente. Con un caveat: a
guardarsi dai giudizi storici (a partire dai miei), e non solo da
quelli su età lontane, che anziché essere più obiettivi di
altri, perché distaccati, ‘scientifici’, nascondono
spesso e volentieri il dominio nel mondo delle categorie del
formalismo giuridico. Diffidare è buona regola sempre, come ci
ha insegnato a fare la mistificante politica del Novecento, ma in
campo storiografico è ormai un imperativo categorico.
Lo impone la
responsabilità morale per quello che si dice e che si va
insegnando. Le categorie storiografiche danno un volto al passato
e in un certo senso accreditano il presente. Perciò
contribuiscono, più di quanto non si pensi, a costruire il
futuro.
[1] Nate come contributo a un incontro organizzato dall’Accademia Jaufré Rudel di Gradisca sull’Isonzo e passate in una prima redazione nella sua rivista, “L’Unicorno”, II, 2000, pp. 9-20.
[2] Forse anche perché ho ormai difficoltà a riconoscermi in una disciplina (per non parlare di gruppi accademici), dopo gli sconquassi preesistenti poi aggravati dalla drammatica riforma dei sistemi concorsuali.
[3] Quella stessa che ha portato a privilegiare in modo abnorme la storia del Novecento; sempre per la storia andrà ricordato ai giovani come la Sinistra – come dire, quindi, la quasi totalità del mondo culturale italiano – avesse sempre sostenuto la fecondità di qualunque corso di storia su qualsiasi periodo storico, purché ben fatto, attento a creare problemi e dare chiavi interpretative.
[4] Si veda L. Ferrajoli, La cultura
giuridica nell'Italia del Novecento, Laterza, Roma-Bari 1999,
p. 13 s.
[5] Il cui rilievo è stato giustamente ribadito da R. Fubini, L’umanesimo itlaiano e i suoi storici. Origini rinascimentali – critica moderna, Franco Angeli, Milano 2001.
[6] Temi sui quali è sempre fondamentale G. Cianferotti, Il pensiero di V. E. Orlando e la giuspubblicistica italiana fra Ottocento e Novecento, Giuffrè, Milano 1980.
[7] Rinvio, per una lettura relativamente
semplice, al mio recente I diritti del Medioevo italiano
(secoli XI-XV), Carocci, Roma 2000, mentre è più complesso
E. Cortese, Le grandi linee della storia giuridica medievale,
Il Cigno Galileo Galilei, Roma 2000.
[8] P. Cammarosano, Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte, La Nuova Italia scientifica, Roma 1993 (ristampe Carocci, ibid.)
[9] Si v. ad esempio A Zorzi, La storia della giustizia. Orientamenti della ricerca internazionale, in “Ricerche storiche” 26 (1996), pp. 97-160, a p. 98, ove si parla del “rinnovato interesse per la storia istituzionale e politica, non più solo nel tradizionale approccio giuridico-formale ma anche nella prospettiva della sociologia giuridica”; la storiografia giuridica vi appare ‘naturalmente’ infetta dal formalismo.
[10] Che ha lasciato tra le tante opere
d'interesse prettamente storico-giuridico una cronaca
'storicissima' del diritto del lavoro: Teorie e ideologie nel
diritto sindacale - 1'esperienza italiana dopo la Costituzione,
Comunità, Milano 1967. C’è da chiedersi, nella situazione
attuale, se si tratti di augurarsi solo un ‘benefico
letargo’, come in S. Cassese, che la storiografia
giuricica si conceda un benefico letargo, in “Rivista
trimestrale di diritto pubblico”, 40, 1990, pp. 1159-1165,
un intervento che è tutto da leggersi molto attentamente, ora in
contemporanea a R. Ajello, L’illusione ontica, in
“L’ape ingegnosa”, 1, 2001, pp. 7-29.
[11] Per cui ad esempio anche in una recente e
rassegna di storiografia medievistica, la produzione giuridica è
stata praticamente ignorata: il Medioevo sembra quello dei
professori di Storia medievale e delle discipline da essa
immediatamente dipendenti da un punto di vista
concorsual-accademico-ministeriale; v. D. Balestracci, Medioevo
italiano e medievistica. Note didattiche sulle attuali tendenze
della storiografia, Il Calamo, Roma 1996.
[12] Sul quale esiste come si sa una letteratura
enorme. V. ora il contesto ricostruito in C. Vano, Alla
ricerca di Gaio, Viella, Roma 2000.
[13] V. ora M. Piccialuti, L’immortalità
dei beni. Fedecommessi e primogeniture a Roma nei secoli XVII e
XVIII, Viella, Roma 1999.
[14] V. ad esempio M. Fioravanti, Stato e
costituzione, Giappichelli, Torino 1997 (ma è solo un
esempio entro una casistica amplissima).
[15] Emerge bene dalla documentazione centro-periferia del tribunale, ora studiata da Oscar Di Simplicio.
[16] Si v. la raccolta di saggi di H. Mohnhaupt, Historische
Vergleichung im Bereich von Staat und recht, Frankfurt am
Main, Klostermann, 2000.
[17] Fu un politico acuto a rilevarlo già tanti anni fa (Pietro Ingrao) sottoponendo ad analisi spietata il sistema delle partecipazioni statali.
[18] Ho cercato di dar rilievo a fatti
strutturali come questo nel mio Istituzioni medievali, il
Mulino, Bologna 1999, alla cui introduzione rinvio per il
formalismo evidente di molte discussioni sullo ‘Stato
moderno’.